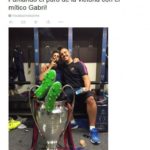Ultimo giorno di scuola
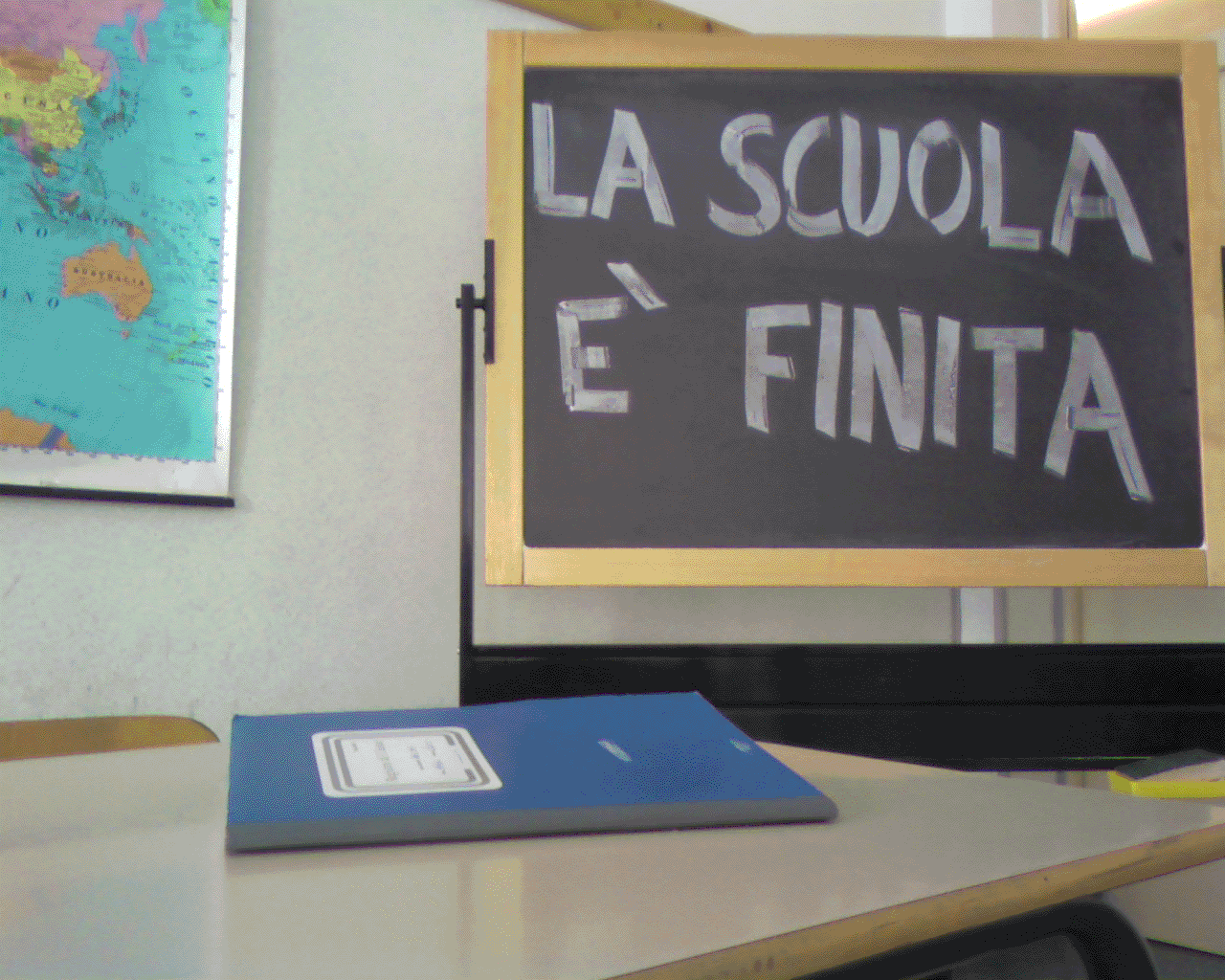
La scuola è finita!
Un'altra volta.
Il bello è che è (sempre) un'interruzione momentanea. Perché la scuola prima o poi ricomincia. Dietro i banchi (i soliti, quelli di formica dura, che guai a scriverci sopra col pennarello indelebile) o fuori registro.
Che si apra o si chiuda, la scuola influisce comunque sulle/nelle nostre vite.
A scuola passiamo le età della vita più lente a passare: l'infanzia, l'adolescenza. Quando siamo lì, sul crinale inconsistente della maturità, siamo magari all'università. Una scuola diversa (da quella dell'obbligo), ma obbligata dai tempi di frequenza (e di tasse!) a essere il più breve possibile.
A scuola impariamo le regole di convivenza (è severamente vietato sputare nell'occhio del compagno, usare il lessico che utilizziamo in famiglia – tipo: mihairottoleballesgomma -, entrare o uscire dall'aula prima del suono della campanella se non si ha una giustificazione adeguata). A scuola impariamo che c'è una distanza: tra cattedra e banchi (ammesso che lo spazio per la distanza sia sufficiente), tra quellochenonsappiamo e quellochedovremmosapere. A scuola capiamo che non siamo soli. Che abbiamo uno, due, tre, dieci, cento compagni di classe o di altre classi che stanno navigando con noi. A scuola ci annoiamo. Pensiamo a quello che ci piacerebbe fare se non fossimo lì con altri venti compagni a una distanza decorosa (ma mai troppo) dalla cattedra.
A scuola diventiamo timidissimi. Arrossiamo per nulla. Tentiamo di fare gli struzzi nascondendo la testa dentro l'Eastpack (che è già pieno di roba puzzolosa). A scuola diventiamo leader. Rispondiamo per le rime (non quelle di Dante) all'insegnante. Intaschiamo la nota disciplinare (che non meritavamo per niente perché quell'altro là la meritava di più) e abbiamo un colloquio col preside, che sì, be', tutto sommato non è niente male ma – dovendo scegliere – avremmo preferito parlare con la nostra amica quella befana. A scuola ci mimetizziamo con l'arredo inesistente: diventiamo una lavagna su cui ciò che viene scritto ha la precarietà e la fugacità fumosa del gesso. A scuola dormiamo in piedi. O seduti su una seggiolina così scomoda che per fortuna che portiamo sempre i jeans se no ci lascerebbe dei segni così sulle gambe. A scuola impariamo i nomi delle bidelle, e anche se le facciamo arrabbiare, l'ultimo giorno le cerchiamo perché un selfie con loro ci sta. A scuola ci andiamo senza merenda, perché tanto ci sono le macchinette. A scuola non ci andremmo il lunedì mattina, e neppure dopo le vacanze di Natale, eppure una volta che ci abbiamo messo piede, ci viene da ridere. O da sorridere. E in fondo pensiamo che ci andremmo pure in agosto piuttosto che passare il tempo a spettinare il gatto che ci ruba il divano.
A scuola portiamo il cellulare, la nostra onnipresente connessione a internet, il nostro profilo fb, dove andiamo a rifugiarci quando la prof ci suggerisce di aprire il libro (libro? o mamma: devo averlo lasciato in corriera) per analizzare la riforma di Clistene.
A scuola capiamo che la Storia è tutta un'altra storia, rispetto alla nostra.
A scuola ci andiamo di corsa se speriamo di incontrare lui (o lei). E non ci andremmo più se lui (o lei) ci hanno tradito e ci viene la nausea al pensiero dell'incontro fortuito.
A scuola ci danno i voti. Ed è l'unica volta (a meno che non abbracciamo la carriera ecclesiastica) che li prendiamo.
E ce li teniamo, che ci piaccia o no. Perché i voti restano impressi nella nostra mente come un tatuaggio.
Sei in filosofia? Ma se Socrate lo sapevo a menadito!
A scuola sperimentiamo il valore della valutazione, dell'incomprensione. Della misurazione e della misura.
A scuola finita siamo ancora quelli di prima. O forse no. Perché nemmeno prima eravamo quelli che credevamo di essere.