La Logica elementare, La prima regola del pensare

La regola di tutte le regole, il codice di tutti i codici, l’algoritmo di tutti gli algoritmi
TESI
Nel concetto di “composizione” possiamo individuare la prima regola del pensare, una regola valida per tutti gli esseri pensanti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi.
DIMOSTRAZIONE
Si può descrivere il concetto su indicato mediante la formula: A + B = C
Con A e B è possibile indicare due qualsiasi unità e con C è possibile indicare, il gruppo, l’insieme, ossia la composizione di A e B.
Rileveremo così che: pensando A+B pensiamo precisamente alla composizione di due unità; pensando C pensiamo ad un’unità composta da A e da B e quindi, ancora, alla composizione di due unità.
La formula in esame ci mostra poi:
- che A, B, C, sono pensate ciascuna come unità determinata;
- che, dopo aver pensato A + B = C, risulta assolutamente impossibile pensare che C non sia composto da A e B
Osserviamo pertanto che ogni atto del pensare nel suo svolgersi segue necessariamente e invariabilmente due principi: il principio di determinazione (o determinatezza) e il principio di coerenza (o non contraddizione).
Osserveremo in particolare che la formula in parola ci consente di vedere con la massima chiarezza come la prima regola del pensare risulti effettivamente sempre pensata per prima. Risulti cioè già pensata prima della formazione di qualsiasi pensiero intorno a qualsiasi cosa.
Si può rilevare facilmente infatti che per pensare A e B singolarmente e distintamente e come unità “determinate” è necessario pensare ciascuna di quelle unità anche come unità composta da propri elementi (o unità componenti). Si rileva pertanto che anche per pensare qualsiasi cosa come unità o cosa determinata è sempre necessario impiegare il concetto di composizione ossia il concetto di A + B = C.
Ancora più precisamente rileveremo che anche per pensare gli elementi (o unità componenti) di A e di B è ugualmente necessario aver pensato prima che anch’essi siano, a loro volta, unità composte da propri elementi, e lo stesso accadrà per pensare gli elementi che compongono tali elementi e gli elementi di questi ultimi e così via.
Dunque il pensare A+B=C risulta sempre pensato prima che si sia pensato intorno a: qualsiasi unità determinata; qualsiasi unità composta; qualsiasi molteplicità di unità; qualsiasi unità o cosa.
Rilevato quanto sopra, non sarà difficile rilevare che il concetto in esame contiene in se stesso come propri corollari le seguenti regole o principi che risultano comunemente accettati come fondamenti indubitabili di tutti quei discorsi che chiamiamo RAGIONAMENTI:
- se A è uguale a B e B è uguale a C allora A è uguale a C;
- se A contiene B e B contiene C allora A contiene C;
- se A, B, C contengono M allora A, B, C, in riferimento e limitatamente a M, sono uguali.
Riteniamo pertanto che la regola descrivibile con la formula A+B=C meriti di essere giudicata e denominata la Regola di tutte le regole del pensare o anche come la Logica prima, o come la Logica base di tutti i ragionamenti, o anche puramente e semplicemente come la Logica.
Qui ci permetteremo di attribuirle il nome di LOGICA ELEMENTARE perché essa è costituita dai primi elementi di ogni atto del pensare.
Noteremo con l’occasione che in riferimento a detta regola “tutte le operazioni del pensiero” (nessuna esclusa) possono essere giudicate come “logiche” (logicamente corrette, logicamente giuste) o “non logiche” (illogiche, incoerenti, contraddittorie) in tanto in quanto abbiano rispettato o meno nel loro svolgimento la composizione della regola stessa.
COME VOLEVASI DIMOSTRARE
Ci si pone ora il seguente interrogativo. È possibile pensare ad una logica diversa, ad altre logiche che non rispettino la logica descritta dalla formula A+B=C?
La risposta ci è fornita già dai risultati delle osservazioni già svolte ed è (evidentemente e indubitabilmente): no.
Osserveremo infatti che per pensare ad una logica (come prima regola del pensare) che sia altra nel senso di distinta e diversa da quella in esame dobbiamo tentare di pensare ad un confronto fra la composizione del pensiero costituita dalla logica A+B=C e un’altra composizione pensabile come distinta e diversa da detta operazione. Constatiamo subito che questo tentativo non si può svolgere se non partendo dal concetto di composizione vale a dire dal pensare A+B=C . Quindi l’operazione non si può svolgere se non per mezzo della medesima logica sulla quale tentiamo di dubitare.
La Logica di cui parliamo risulta dunque pensata come:
- originaria in quanto necessariamente prima, non derivata né derivabile da altre regole;
- assoluta in quanto fondata su se stessa, ed escludente qualsiasi altra regola diversa che ne costituisca il fondamento;
- universale in quanto uguale per tutti gli esseri o soggetti pensanti in ogni tempo e luogo.
Gli argomenti sopra esposti, consentono, a sommesso parere di chi scrive, di giudicare come dimostrata la teoria sopra enunciata.
Si ammetterà naturalmente che la teoria stessa resti aperta a ogni possibile discussione.
Chi scrive si limita ad esprimere questa discutibile opinione. La logica elementare si presenta come uno strumento che ci consente di distinguere i discorsi logici da quelli che non lo sono. E con ciò rende più facile la soluzione di un numero molto alto di problemi grandi e piccoli del vivere umano.
(Brano dal libro Pensiero del limite e limite del Pensiero di Giorgio Pizzol)
V Dia blog La Logica Elementare La dimostrazione di Deepseek
Libreriauniversitaria Giorgio Pizzol Pensiero del limite e limite del pensiero.htm
Youcanprint.it Pensiero-del-limite-e-limite-del-pensiero


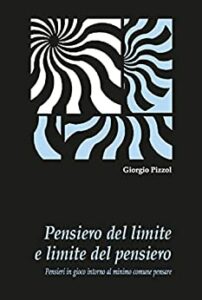
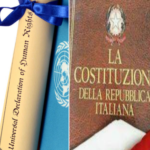

Io posso anche essere d’accordo che esista una definizione comune a tutti, per questi argomenti; ma il punto è che non appena si inizia ad approfondire, nella discussione del singolo termine entra in gioco tutta una serie di chiavi di lettura soggettive: date dall’esperienza dei singoli, dalla loro cultura, ecc.
Ora, considerate le mie scarse conoscenze in ambito filosofico, non voglio affermare che discutere su tale teoria sia un’oziosa perdita di tempo; ma di sicuro che tale particolarità (la “definizione univoca” da cui siamo partiti) diventa nella realtà dei fatti solo un dettaglio secondo me poco significativo.
È un po’ il ragionamento che va fatto riguardo alle ideologie e alla loro controparte su base irrazionale, le dottrine religiose: sono formule universali, ma che se vengono applicate pedissequamente alla realtà delle cose, provocano solo un sacco di guai.
Gentile Alberto Rizzi, intanto la ringrazio per essere intervenuto su questo tema. Rispondo alla sua osservazione.
Lei dice: “Io posso anche essere d’accordo che esista una definizione comune a tutti, per questi argomenti”.
Ecco a me bastava che lei dicesse solo questo. Infatti io sostengo la tesi che esiste “un Minimo comune pensare” che contiene in se stesso (nel minimo) i temi fondamentali di cui si occupa quella materia di studio denominata “Filosofia”. Non escludevo affatto che non si possa andare oltre il minimo.
A me premeva dire che questo Minimo è il fondamento di tutti i pensieri e che pertanto deve essere pensato come universale, valido in ogni tempo e luogo.
Prendere coscienza dell’esistenza di questo minimo, secondo me, è importantissimo perché consente a tutte le persone di comprendersi e di essere d’accordo, se non altro su questo Minimo.
Mi permetta di dirle che non dovrebbe dire di avere “scarse conoscenze in ambito filosofico” visto che in questo scritto non ci si riferisce a nessun filosofo, famoso o non famoso. Si parla solo del concetto di “Composizione” e sono sicuro che lei abbia chiarissimo questo concetto. Come del resto, io direi, che lo ha chiarissimo qualsiasi persona in tutti i tempi luoghi e in qualsiasi condizione sociale o culturale.
Il discorso naturalmente resta aperto. Resto volentieri a sua disposizione se lei lo vorrà continuare.
Sul tema può dare un’occhiata a questi articoli di Dia blog. Logica elementare, la dimostrazione di Deepseek. Enrico Berti su pensiero del limite e limite del pensiero. Il trattato di filosofia più breve del mondo.